|
SUI PRIMI INCONTRI MANCATI
- D: so che state conducendo in questi mesi un’azione di ricerca con gli studenti di Roma Tre sugli abitanti delle baraccopoli del Tevere e che state organizzando diverse azioni artistiche per contrastare i nuovi Patti della Sicurezza firmati da Veltroni a Roma e da altri sindaci di altre città italiane. Vorrei che me ne parlassi ma prima mi piacerebbe sapere quand’è che avete cominciato a lavorare con i rom e quali sono state le prime esperienze di Stalker con l’universo nomade. Ti chiederei però di non parlarmi del “vostro nomadismo” inteso come categoria filosofica o come pratica estetica, ma delle popolazioni “nomadi” che oggi vivono tra noi e che riempiono le pagine della cronaca. Come vi siete avvicinati ai rom? - R: il percorso è stato abbastanza lento, è stata una conoscenza progressiva durata più di dieci anni. Nessuno di noi aveva mai avuto prima una relazione diretta e direi che questo percorso è stato un’importante crescita comune. Siamo partiti da zero. Nella prima transurbanza fatta a Roma nel 1995 ricordo che siamo passati di fronte all’ingresso del campo di Quintiliani e che non ci siamo entrati. Era tardo pomeriggio, eravamo stanchi e cercavamo un posto dove fare l’accampamento per la notte. Ci siamo fermati in un campetto di calcio che degli albanesi avevano allestito per i propri bambini. Mi ricordo che avevamo parlato con un uomo alto bellissimo, con capelli lunghi, occhi azzurri profondi e un’aria da saggio, sembrava Melquiades, quello zingaro dei Cent’anni di solitudine di García Márquez che portava a Macondo le novità del mondo, e che all’inizio del libro aveva stupito il villaggio mostrando il ghiaccio. Melquiades e gli altri albanesi avevano preso un vecchio casale della campagna romana e lo avevano trasformato in una casa per più famiglie, un ambiente accogliente e ospitale. Alla nostra richiesta di dormire nel campetto dei loro figli ci avevano risposto che erano felici di avere ospiti, che potevamo montare le tende e nessuno ci avrebbe dato fastidio. - D: così decideste di chiedere ospitalità agli albanesi e non ai rom, anzi magari gli chiedeste di difendervi nel caso aveste avuto problemi da loro. È andata così? - R: no, non chiedemmo protezione. Ci rivolgemmo agli albanesi, il loro casale ci dava sicurezza più di quell’ammasso di tetti di lamiera e di stradine fangose. Ti dico che non avevamo neanche per un momento avuto la curiosità di entrare… anche se in realtà un anno dopo, nel percorso a piedi che facemmo a Torino, in un campo rom ci entrammo, e ci fermammo un bel po’ a parlare con i bambini... ma in quel primo giro di Roma non successe… non saprei spiegartelo… non è successo e basta. I rom d’altra parte non li avevamo neanche incontrati, mentre gi albanesi si. E comunque l’idea di chiedere ospitalità per la notte ai rom non ci aveva sfiorato. Mentre oggi è proprio questo che siamo organizzando. - D: ma oggi avresti una spiegazione? Avevate avuto paura? Ma voi non eravate lì a camminare per abitare i vuoti del territorio? Quello non era un “vuoto”? - R: si, capisco il tuo stupore, oggi un campo nomadi attira subito la nostra attenzione, ci avviciniamo, cerchiamo di capire chi sono, da quanto tempo sono lì, da dove vengono, abbiamo un enorme curiosità. Ma a quell’epoca, seppure eravamo intrisi di miti sul nomadismo, entrare in un campo nomadi semplicemente non era nel nostro genere di pensieri. Non so spiegartene le ragioni. Sicuramente per noi era un vuoto, nella mappa del Planisfero Roma quel campo era blu come il mare dei vuoti, e credo che se avessimo rappresentato le profondità di quei mari, il campo rom lo avremmo fatto di un blu profondo. - D: e già, un abisso nei mari di Roma. Un’ “amnesia urbana” delle più intense e dimenticate. E voi non entrandoci stavate cancellando dai vostri territori mentali una delle zone più importanti della “città inconscia”, o dei “Territori Attuali”, come li chiamavate voi. - R: in qualche modo si. Non ti so dire se non eravamo ancora pronti o se eravamo ancora vittime della cultura del pregiudizio. È vero, andavamo tutto il giorno scavalcando cancelli, recinzioni e proprietà private, ma lì in quel campo, dove la porta era aperta e dove non si sarebbe dovuto scavalcare, forse le nostre barriere mentali ci avevano impedito di accedere. Stavamo eliminando una parte della mappa e questo fatto non fu neanche assunto o analizzato, lo facemmo senza una riflessione, senza cercare una scusa o porci un dubbio. Mi fa pensare a chissà quante cose ancora oggi non riusciamo a vedere nei territori che attraversiamo, a quanti lati ci sfuggono perché in fondo non li vogliamo vedere. Anche noi che di questo “andare a testimoniare i fenomeni emergenti del territorio” ne abbiamo fatto un lavoro… - D: beh capisco che a quell’epoca voi eravate più in cerca di paesaggi entropici e di natura ibrida e che prestavate meno attenzione agli abitanti. È più tardi che quello spazio naturale ha cominciato a trasformarsi per voi in spazio abitato, in reti di relazioni umane. Andiamo avanti, quando siete entrati in contatto veramente con i rom? SUI ROM DEL CAMPO BOARIO - R: è successo quattro anni più tardi, nell’estate del 1999, quando abbiamo dato vita con i curdi al progetto di Ararat nel Campo Boario di Testaccio. E lì che siamo entrati in contatto per la prima volta con l’universo rom. Mi ricordo molto bene il primo incontro, un’occasione quasi ufficiale. Ci fu una riunione al Villaggio Globale con i capi famiglia, si doveva decidere il rientro dei rom nel piazzale. Erano andati via due mesi prima proprio per far posto alla Biennale d’Arte dei Giovani e del Mediterraneo, la stessa che aveva portato lì noi. Di quella sera ricordo tutti gli uomini rom, facce stanche e chiari nei loro propositi. Era in gioco il loro abitare, il loro vivere e non avevano altre alternative. Ed era sorprendente vedere quanto l’assemblea del Villaggio Globale sapesse trattare con quelle persone. Gli occupanti del centro sociale chiedevano assicurazioni per la scolarizzazione dei figli, per la pulizia generale del Campo Boario, si accordavano per l’uso dell’elettricità e dell’acqua… insomma quella sera abbiamo assistito alla stesura delle regole di buon vicinato tra la comunità rom ed un centro sociale, un patto fondato sulla parola, una rinnovata alleanza. Quella notte i rom rientrarono nel loro piazzale e vi rimasero fino a poche settimane fa, altri otto anni. Misero in circolo i loro grandi camper superattrezzati, le loro macchine sfavillanti, le tende per le verande, quelle per la lavorazione dei metalli, quelle per gli sgabuzzini, i tavoli, le lavatrici e i fili per stendere i panni, le pompe dell’acqua che rimanevano sempre aperte. Mandarono i figli a scuola, anche con buoni risultati, il campo era sempre pulito e le relazioni con tutti gli altri sono sempre state cordiali. - D: e com’è stato il primo vostro ingresso nel campo dei rom? - R: mah il primo ingresso non me lo ricordo. È stata una cosa avvenuta progressivamente. Sai, fino al 2004 non c’erano mai state recinzioni, quindi non era un campo ma una sorta di accampamento, e chi passava nella strada centrale ci passava praticamente dentro, c’era una sorta di confine non stabilito. Non c’era una porta in cui entrare, l’ingresso era libero e filtrato al tempo stesso. Passata una certa soglia ci si sentiva gli occhi addosso. Poi alla domanda “c’è Aldo?” ed a un cenno di assenso la vita ricominciava a scorrere come prima, le donne al lavoro, gli uomini a discutere, i bambini a giocare e tu potevi camminare. - D: per entrare in un insediamento rom dunque è bene avere un nome da cercare. In fondo è come quando si entra nel cortile di un condominio, l’unico lasciapassare è il dichiarare da chi vai. Ma voi che ci andavate a fare da Aldo? - R: Aldo Hudorovich è una sorta di rappresentante della comunità. Era a lui che raccontavamo i nostri propositi, lui ci presentava e si faceva portavoce dei nostri progetti presso la comunità. Il ché non voleva dire che il coinvolgimento c’era stato. Chi metteva in moto le famiglie erano i bambini, erano loro i più incuriositi dalla nostra presenza, i più contenti per i dispositivi ludici che costruivamo nel Campo Boario. Non posso immaginare cosa ricordano oggi della giornata del Globall Game quando il piazzale era stato invaso da centinaia di palloni da calcio e cento persone continuavano a prenderli a calci da una parte all’altra, un gioco inarrestabile e irresistibile anche per gli adulti. Lentamente infatti dopo i bambini arrivano i ragazzi più grandi, poi le mamme, infine i capi famiglia. È così che è incominciata la relazione. Dopo alcuni mesi le donne hanno smesso di voler leggerci la mano e hanno cominciato ad offrirci il caffè o a volte un pranzo, i ragazzi hanno smesso di far la parte dei bulli e di dirci di stare attenti al portafogli, gli uomini hanno smesso di osservarci in modo sospettoso. Alla fine tutti si sono stufati di portare la maschera da nomadi e si sono rivelati per ottime persone quali sono. Con Aldo continuiamo a lavorarci, è stato molto importante anche sul progetto del Tevere che stiamo facendo ora. - D: so che tutto questo è anche merito di Matteo Fraterno? Che è lui l’artista che ha cominciato a lavorare in stretto contatto con loro? - R: Matteo è stato molto importante, è napoletano ed ha un’incredibile capacità di costruire relazioni e di entrare in profondità nelle realtà con cui lavora. Noi avevamo già lavorato insieme alla comunità in varie occasioni, a cominciare dal Pranzo Boario, dove Lorenzo era riuscito a coinvolgere la moglie di Aldo a cucinare un ottimo gulasch da mangiare insieme agli altri piatti tipici delle altre comunità in una grande tavolata rotonda nel piazzale. I rom erano venuti, avevano mangiato, ballato e avevano fraternizzato con i curdi. In seguito abbiamo organizzato con loro un workshop, il titolo era Rom(a) e abbiamo cominciato a comprendere meglio tante cose. Poi è arrivato Matteo con “Serenate”, ha portato una banda di musicisti, artisti, amici, un sacco di gente tra i camper per fare un finto matrimonio zingaro. Un’ idea sensazionale insomma, delle sue. E in effetti è stata la prima volta che abbiamo invaso in tanti l’interno del loro piazzale, e che abbiamo fatto un’azione direttamente in casa loro. Da quel momento Matteo è diventato un personaggio per tutti gli zingari. E questo è stato importante per conquistare la fiducia di Tomo e Milka, i due anziani che gli hanno raccontato del loro internamento nel campo di concentramento di Agnone nel ’41. È stato nel gennaio del 2004, quando abbiamo organizzato il progetto “Samudaripen” (che in romanès vuol dire “olocausto”, tutti morti) in occasione della giornata della memoria per la Shoa. Ne è nato un ottimo lavoro, in seguito Milka è tornata al campo di concentramento con noi e Matteo ed ha ottenuto dal sindaco la cittadinanza onoraria. Un vero lavoro di arte pubblica. - D: da come parli mi sembra quasi che per voi il l’accampamento di Testaccio sia un habitat ideale? Perché tanto interesse per questo mondo? Voi vorreste vivere cosi? - R: ma intanto ti dico che il caso di Testaccio era sicuramente un caso estremo di benessere economico e sociale e che quell’accampamento di roulotte non aveva nulla del degrado in cui versano altri campi della capitale. Era sempre pulito, c’erano anche sette laboratori per i metalli e il lavoro non mancava. Tra le persone sedute in veranda sembrava quasi di stare in un campeggio estivo. Oggi dopo aver fatto visita a tanti altri campi quello di Testaccio mi sembra veramente una grande eccezione. Come habitat quello è l’unico esempio positivo che mi sento di fare. Per il resto qui a Roma la maggior parte dei campi è un inferno non invidiabile da nessun essere umano. Su cosa ci attirava, oltre al desiderio di conoscenza, ti risponderei in una sola battuta: lo stile di vita. È proprio un altro modo di stare al mondo, per certi tratti veramente invidiabile, anche se non credo potrà mai essere il mio. E comunque non è che accettassi tutto della loro cultura, siamo molto diversi e non riuscirei a vivere con le loro regole comunitarie. Ma quel mondo non è poi cosi lontano, è qualcosa che in qualche modo ci appartiene, che abbiamo dentro e che dovremmo frequentare per ritrovarlo in noi da qualche parte. Per conoscerlo dobbiamo riconoscerlo. È per questo che ci sembrava importante invitare i cittadini a conoscerlo. Ma comunque ora tutto questo non c’è più, entri al Campo Boario e c’è il cantiere per il mercato dell’economia equa e solidale… sembra assurdo ma è così. - D: si lo so, sono stati sgomberati il 4 aprile per fare posto alla Città dell’Arte e dell’Altra Economia. Sono stati ricacciati via un’altra volta dall’Arte e questa volta definitivamente. Sembra quasi un paradosso, il Comune ha ripulito tutto come se l’arte non dovesse occuparsi della realtà e se i rom non fossero esattamente l’altra economia. Eppure i rom calderasha di Testaccio erano noti per la loro grande integrazione con il quartiere, mi sembra assurdo che sia finita così. Ma una soluzione non si sarebbe potuta trovare? Loro cosa avrebbero voluto, come vorrebbero abitare? - R: ma si, il Sindaco avrebbe potuto risolvere la situazione egregiamente e poi anche portare il risultato come un fiore all’occhiello. Non solo da mostrare come esempio per chi invoca più sicurezza, ma anche come traguardo possibile per le altre comunità rom cittadine che vivono nel degrado ambientale e sociale. In fondo chiedevano un terreno, un piazzale dotato di luce acqua, avrebbero pagato regolarmente le bollette. Se fosse stato un terreno agricolo avevano anche proposto di comprarlo. Abbiamo anche fatto dei giri insieme a loro per cercare dei terreni possibili, ma poi non se ne è fatto più niente, il tutto è passato dall’assessorato all’urbanistica a quello delle politiche sociali, e adesso direttamente alla prefettura. - D: è incredibile che l’abitare di queste persone non sia di competenza dell’urbanistica ma sia solo un problema di pubblica sicurezza. Sono più di ventimila persone da sistemare a Roma, com’è possibile che urbanisti e architetti non se ne occupino? - R: ma guarda in realtà, a parte le solite associazioni che da anni offrono assistenza, di tutto questo non se ne occupa nessuno. E in molti campi non entra veramente mai nessuno, solo la polizia, che spesso entra nelle loro case senza permesso di perquisizione. Anche i giornalisti hanno paura di entrare in un campo, ci vanno solo quando succede qualcosa di grave, tutti insieme e magari scortati. È per questo che mi sembra importante portare gli studenti nei campi, fargli conoscere queste realtà serve a cominciare a scalfire i pregiudizi, ad assottigliare i muri di difesa, intendo dire reciprocamente, sia per gli studenti che per i rom. SUI LETTI DEL TEVERE - D: siamo finalmente a quello che state facendo oggi, all’azione di ricerca “Sui letti del fiume e all’Atlante dell’abitare sul Tevere”. Da dove nasce il progetto e in cosa consiste? - R: il progetto è nato un anno fa da una proposta di Kristin Jones di fare un lavoro per la “Piazza Tevere” inaugurata da lei tre anni fa con una bellissima installazione di lupe tiberine disegnate sugli argini. Noi da tempo pensavamo di approfondire il tema dei rom e di comprendere le relazioni tra Rom, Rumeni e Romani (all’inizio era questo il titolo del progetto). Così abbiamo deciso di camminare lungo tutto il Tevere e di raccontarlo il tutto in un Atlante in collaborazione con il corso di Arti Civiche della Facoltà di Architettura di Roma Tre. La camminata è diventata il programma del corso e a marzo sono cominciate le esplorazioni a partire dalla foce, da Ostia e Fiumicino. Un corso interamente svolto in città e fuori dalle aule della facoltà, in cui a camminare erano gli studenti, i membri di stalker/osservatorionomade e diversi ospiti: una carovana molto eterogenea per età e formazione che ogni giovedì si divideva in due gruppi di una ventina di persone ciascuno per camminare in parallelo sulle due sponde dal pranzo al tramonto. - D: e come si svolgono le camminate? Chi avete incontrato? - R: si cammina tra i canneti, su un sentiero che spesso evapora lentamente, e allora bisogna aprirselo davanti ai piedi, tra i rovi e le ortiche. Poi a volte dal sentiero principale si stacca un sentiero secondario che scende sul greto, si cominciano a vedere dei panni stesi, si sentono delle voci e noi cominciamo a chiedere “c’è nessuno? È permesso”. > |
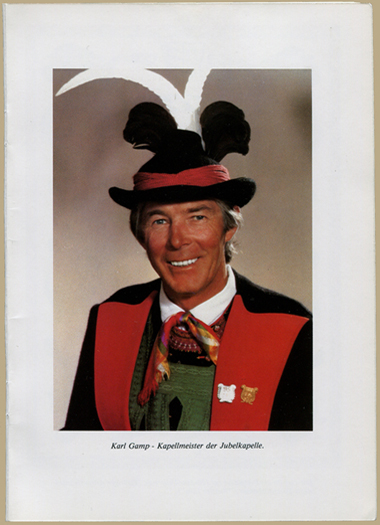 |
|||||||
|
Roma (Italy) 25 luglio 2007
|
||||||||
|
Ci presentiamo dicendo di non essere né la polizia né dei giornalisti e spiegando quello che stavamo facendo. Ne nascono delle normali conversazioni di solito a partire dalle loro storie personali, perché abitano lì, da dove vengono, che lavoro fanno, come vivono, se vogliono restare lì per tanto tempo o è una soluzione temporanea, se hanno desideri abitativi particolari, se hanno costruito loro la baracca o l’hanno trovata o l’hanno comprata a qualcuno, se hanno acqua e luce, se qualcuno viene mai a fargli visita. Spesso ci è stato offerto un caffè o dell’acqua, insomma quasi sempre il tutto si è svolto in un’atmosfera molto conviviale. Altre volte invece o per la lingua o per la diffidenza, non siamo riusciti a dialogare, solo in due casi siamo stati allontanati.
- D: e insomma chi sono? Quanti sono? Sono tutti nomadi? - R: no non sono tutti nomadi e comunque questa parola è già sbagliata. L’altra sera eravamo a cena con Aldo e lui ci ha chiarito un sacco di cose che noi avevamo solo intuito, un sacco di informazioni utilissime a sbrogliare questa matassa ingarbugliatissima del “problema nomadi”. Il comune chiama “nomadi” a Roma circa 20.000 persone e mette sotto questo appellativo dispregiativo una quantità di realtà differenti che in realtà di nomade non hanno niente. Aldo dice che come loro, di famiglie “transitanti”, a Roma ce ne sono una ottantina, non si arriva neanche a cento, insomma secondo lui A ROMA I NOMADI NON SONO PIU’ DI 400 PERSONE!!! Ti rendi conto? Se il problema fosse questo sarebbe già risolto. Queste quattrocento persone chiedono solo di potersi spostare e fermarsi con i loro camper dove vogliono, come hanno fatto per anni, fino al ’95, quando il campeggio è stato vietato in tutto il territorio comunale. Invece a Roma le aree di transito non sono mai state fatte. In tutta Italia ce n’è solo una ad Arezzo, mentre ce ne dovrebbe essere una in ogni comune superiore i 15.000 abitanti, come i “terrains pour les gents de vojage” che ci sono in Francia. Insomma trovare una soluzione per i nomadi a Roma non mi sembra impossibile… - D: ma scusa se solo 400 sono nomadi, gli altri 20.000 chi sono? - R: è questo il punto: SONO PROFUGHI. Sono profughi di etnia rom. I primi ad arrivare in Italia negli anni ‘90 sono stati quelli che fuggivano dalla ex Jugoslavia, sono serbi, bosniaci, kosovari, macedoni… oggi invece molti vengono dalla Romania e a questi si sono mescolate molte persone non rom, o “gagè” come si dice in romanès, che spesso vivono accanto o dentro ai campi rom, affittando le baracche rimaste vuote. Ma la cosa più importante è che tutte queste persone, prima di venire in Italia non erano nomadi, nel senso che non transitavano, ma da secoli erano oramai sedentarizzati ed abitavano in “case”, a volte anche al quinto piano di una casa popolare, capisci cosa intendo dire? Non hanno una cultura abitativa dell’abitare “nel campo”, è che qui in Italia sono stati chiamati “nomadi” e quindi mandati ad abitare nelle baracche! Insomma non si può parlare di “campi nomadi”, sono dei CAMPI PROFUGHI come ce ne sono oggi in tutto il mondo, luoghi dove ogni diritto viene sospeso e dove la il concetto di legalità diventa sempre più ambiguo. Persone private dei diritti fondamentali e ridotte a vivere in condizioni agghiaccianti. - D: è incredibile. Ma di che cosa vivono? Come fanno a campare? - R: ma non c’è una risposta univoca ed è molto diversa per rom e gagè. I rom transitanti hanno ancora abbastanza lavoro, lavorano i metalli, lucidano oggetti sacri delle chiese, pentole e posate di caserme e ristoranti. Insomma viaggiano per procacciarsi il lavoro in tutta Italia, e forse oggi potrebbero anche lavorare solo nell’area metropolitana di Roma, tanto è cresciuta la città. Ma comunque a loro piace stare in giro… Per gli altri rom il lavoro è un problema, nessuno gli dà un lavoro, i pregiudizi sono enormi. Fanno lavori alla giornata, suonano nelle metropolitane, lavano i vetri ai semafori, molti vivono di sola elemosina, altri raccolgono materiali usati e li riciclano, e altri hanno attività illegali, è innegabile. Non lo condivido ma mi rendo conto che quando hai dei figli e la sera gli devi portare qualcosa da mangiare alla fine sei anche costretto a farlo. E comunque per la maggior parte sono solo piccoli furti di sostentamento non sono malavita organizzata, anche se recentemente nei campi sono entrati lo sfruttamento della prostituzione e lo spaccio di cocaina, e questo molto preoccupante. Ma per la maggior parte è un po’ la vita che si faceva nelle baraccopoli degli anni ’50, in certi momenti sembra di essere in un film neorealista, in “ladri di biciclette” o “miracolo a Milano” o “i soliti ignoti”, qualcosa che la nostra cultura conosce molto bene insomma. - D: e gli altri, quelli che dicevi non essere rom, ma che vivono nelle baracche? - R: sono moltissimi e sono soprattutto rumeni, ma ci sono anche moldavi, polacchi… loro hanno un accesso molto più facile al lavoro. Tanti hanno lavori di fortuna, fanno gli operai a giornata, lavorano sottopagati e in nero nei cantieri edili, alcuni hanno anche la partita iva, molte donne che abbiamo incontrato fanno le badanti, altre le colf… insomma sono persone che vivono quotidianamente tra noi. Solo che con quello che gli diamo non riescono a pagarsi un affitto, sarebbero espulsi da questa città se non si fossero costruiti le baracche. A Roma un letto su cui dormire a turno di giorno e di notte costa anche 200 euro, una camera più di 400 euro, lo stesso prezzo di una baracca scassata, senza ruote, intorno a cui ci si può costruire una veranda, altre stanze, la cucina, un bagno nel canneto, insomma un habitat completo, spesso anche dignitoso e con vista sul fiume. Abbiamo visto anche delle situazioni accettabili, insomma, comunque meglio di un appartamento iperaffollato con un letto su cui turnarsi. - D: prima parlavi degli anni ‘50, so che avete invitato anche Giovanni Berlinguer, oggi parlamentare europeo, ma in quegli anni autore insieme a Cesare della Seta del famoso libro Borgate di Roma. Cosa vi ha raccontato? - R: è stato un incontro molto bello. Ci ha raccontato di quando al posto di rumeni e dei moldavi c’erano siciliani e calabresi. Stavano negli stessi posti peraltro, nel libro c’è una descrizione delle baracche dell’Aniene che sembra la stessa di oggi. Ci ha detto che il libro era nato da una grande nevicata di tre giorni della primavera del 1956. Roma era bloccata e allora un gruppo di intellettuali del PCI erano andati a portare i primi aiuti alle baraccopoli. Erano una ventina e andavano a piedi, tra gli altri c’erano Pasolini, Moravia, Pontecorvo, Lizzani. Ma a quel tempo la povertà la conoscevano tutti, era appena finita la guerra, c’erano comitati di lotta, gruppi organizzati, il partito, i sindacati, i preti baraccati. È da lì che sono nate le lotte per la casa e infine le leggi per l’edilizia economica e popolare. Oggi i partiti sono assenti, queste persone non portano voti e occuparsi di loro ne fa anche perdere di voti. A destra e a sinistra si fa la gara a chi chiede più sicurezza, se la prendono con queste persone solo perché vivono nelle baracche. Prima c’erano gare di solidarietà, oggi il comune di sinistra gli chiude le fontanelle, disattiva le fermate delle metropolitane, li lascia vivere nell’immondizia senza neanche portargli un cassonetto, gli demoliscono le baracche senza preavviso, con tutte le loro cose dentro, un incubo. Li stanno cacciando rendendogli la vita impossibile. Abbiamo anche incontrato persone che seppure nate per la terza generazione in Italia, ancora non hanno la cittadinanza italiana. Non si capisce come si fa a chiedere a queste persone di rispettare le regole se i primi a non rispettare i diritti umani siamo noi, non si capisce come chiedere doveri se non gli diamo i diritti che gli spettano. SUI PATTI DI SICUREZZA - D: mentre stavate conducendo l’inchiesta sul Tevere sono stati firmati i Patti della Sicurezza, proposti dal Ministro degli Interni Amato e poi sottoscritti dai prefetti, dai sindaci e dai presidenti di regioni e province. So che a Roma per risolvere il problema della sicurezza è stato deciso di allontanare tutti “ i nomadi” dalla città e di costruire per loro quattro grandi campi da mille persone, fuori dal Grande Raccordo Anulare. Li chiamano Villaggi della Solidarietà. Mi sembra orribile, voi che ne pensate? - R: è una cosa gravissima, che non è mai successa nella nostra storia democratica, una vera svolta autoritaria, pericolosa perché demagogica e razzista. Hanno trovato il capro espiatorio nel “nomade” e adesso lo mettono alla gogna come dice Padre Sardelli nella sua lettera al Sindaco, “si vuole colpire i poveri invece di colpire la povertà”. Ci sono migliaia di persone, uomini, donne e bambini, che dovranno pagare per le malefatte di alcuni. Si colpisce l’etnia e non il singolo. I primi a contestare i patti sono stati gli “ebrei per la pace”, loro la conoscono molto bene questa storia, hanno detto che si tratta senza mezzi termini di deportazione etnica e di campi di concentramento. In questi quattro campi andrebbero a vivere l’uno accanto all’altro popoli che scappano dalle stesse guerre, i bosniaci insieme con serbi e con i kosovari… sarebbe una vera miscela esplosiva. E li vogliono mettere lontano dalle aree abitate e dai collegamenti per non farli più ritornare in città, per renderli invisibili in favelas di container, recintate, con guardiania all’ingresso. Dentro ci sarà una ambigua sospensione della legalità, come nei CPT, e nessuno potrà sapere cosa vi accade, col tempo ce li dimenticheremo. - D: effettivamente è agghiacciante. Ma voi a che alternative avete pensato? Cosa proponete? - R: intanto diciamo al Sindaco e al Prefetto che il problema è complesso e che deve essere affrontato in modo complesso, non si può semplificare il tutto con quattro campi. Si vogliono eliminare i 23 campi legali riducendoli a 4, e allontanare con la forza gli abitanti dei 30 campi illegali della città (numero molto sottostimato visto che solo sul Tevere noi di illegali ne abbiamo trovati 54…) noi crediamo invece che con i 15 milioni di euro stanziati per i nuovi campi, si dovrebbero riproggettare da capo i 23 campi legali, con tipologie diversificate, in alcuni casi anche a più piani, e che si potrebbe fare il tutto in autocostruzione con evidenti risparmi e maggiori garanzie sulla manutenzione. Vedi qui l’amministrazione e tutti quelli che si occupano dell’abitare sono rimasti veramente molto indietro. Qui a Roma autocostruzione è sinonimo di abusivismo. E come soluzione alla baracca si ipotizzano solo case popolari, il ché fa diventare la soluzione quasi impossibile, dato che non se ne fanno più da anni. Noi crediamo invece che vada superata la logica del campo, estranea alle culture rom, e che tra la baracca e la casa popolare ci sia un ventaglio enorme di possibilità abitative che sono inesplorate e che potrebbero essere buone soluzioni anche per chi non è rom. Che insomma tutto ciò potrebbe positivamente influenzare anche la nostra maniera di vivere. - D: ma queste 23 aree esistenti in che senso sono legali? Da quanto esistono? Dove sono? - R: sulla legalità dei campi si apre un enorme buco legislativo. Sono li a volte per una semplice ordinanza del sindaco, magari si chiamano ancora “campi provvisori” dopo venti anni. Sono stati creati con l’arrivo dei profughi dei Balcani, prima non esistevano, e comunque oggi nessun rom li vuole. La domanda che viene da queste comunità è di piccoli insediamenti di poche famiglie, sparse in tutta la città. Ma il problema è anche di tipo speculativo, perché queste 23 aree sono sotto una forte pressione della speculazione edilizia. È chiaro che una volta che i nomadi se ne saranno andati i prezzi saliranno immediatamente. Come è chiaro anche che si utilizzeranno i quattro campi, di cui ancora non si sa la localizzazione, posizionandoli qui e là fuori dal GRA per rendere edificabili porzioni di campagna romana e far abbassare i prezzi delle aree. In questo modo i costruttori potranno comprare e quando poi si deciderà che l’area non è idonea per il megacampo, i costruttori potranno cominciare a costruire su quei suoli comprati a prezzi stracciati, costruendo quartieri abominevoli, sfruttando i rumeni in nero, senza sicurezza nei cantieri… i problemi in realtà sono tutti collegati e come al solito fanno capo alla rendita fondiaria e alla speculazione edilizia. Quei 23 campi devono rimanere dei “nomadi”, se li sono guadagnati abitandoci per venti anni, con enormi sacrifici. Non devono diventare né nuove palazzine né parchi pubblici. Devono rimanere destinati ai rom. - D: di tutto questo nessuno ne parla, voi pensate che si possa costruire un opinione pubblica in favore dei rom e dei baraccati, non vi sembra un po’ utopico? - R: si questa posizione è decisamente minoritaria, proprio perché il problema non lo si conosce, la stampa sia di destra che di sinistra non fa altro che etnicizzare ogni fatto di cronaca e questo peggiora le cose. Secondo me tra venti anni ci vergogneremo di quello che stiamo facendo ai nuovi paria. I “nomadi” sono invisi a tutti e i pregiudizi sono radicatissimi anche tra le persone più vicine a noi. È per questo che bisogna trovare il modo con cui costruire un consenso, a partire dalla conoscenza del problema. Due settimane fa abbiamo fatto un appello alla cittadinanza di venire a dormire sotto Ponte Garibaldi, in pieno centro. Uno sleep-out di solidarietà e per contestare i patti di sicurezza. Ha funzionato, sono venute un migliaio di persone e un centinaio ha dormito in tenda. Adesso stiamo lavorando a una visita pubblica al campo di Castelromano, dove ci i sono rom sgomberati dal centro e che ora si ritrovano lungo un’autostrada a venti chilometri da Roma. Sono senza acqua potabile, in filari di container. Per l’amministrazione è un “campo attrezzato”, ed è spesso stato citato come il modello per i nuovi quattro campi. È importante portare la gente a vedere che cosa si vuole fare. |
||||||||
|
|
|
|||||||